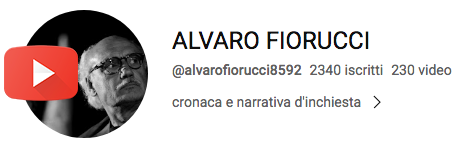Una faida esportata: il piombo della ‘ndrangheta in un parcheggio di periferia
 I primi spari della faida tra due famiglie della ‘ndrangheta si erano sentiti a Strongoli. Pistole e kalashnikov avevano fatto fuoco in tutta la provincia di Catanzaro per stabilire chi fosse il padrone del mercato della droga e degli altri affari sporchi che danno soldi e potere. Poi il crepitìo delle armi si sentì anche più a nord. Fino a Perugia, dove il 26 aprile 1991 i proiettili 7,65 di un intero caricatore fecero l’ennesima vittima. Aveva 23 anni , si chiamava Luigi Castiglione e tre anni prima era arrivato dalla Calabria per fare il muratore a Magione. E’ un anonimo che poco prima delle 21 chiama il ”113” , camuffata la voce, sintetica la prosa : “tra Elce e San Marco ci sono un’ auto e un morto ammazzato”. Un quarto d’ora e una pattuglia individua il posto: è il parcheggio di un albergo noto più che altro per il ristorante. Gli agenti vedono prima una macchina, poi un corpo steso per terra, e tanto sangue intorno. Luigi Castiglione è vivo, il telefonista s’è sbagliato. Ma di poco: la missione dei killer si completerà tra meno di tre ore quando il giovane morirà sotto i ferri di una sala operatoria del Silvestrini. Le indagini , coordinate dal sostituto Michele Renzo, con un giro sui terminali, accertano che la vittima aveva precedenti gravi e significativi: droga, tentato omicidio associazione mafiosa. Accertano anche che un suo fratello Francesco, 26 anni, era stato ucciso un anno prima, il 7 febbraio, con una raffica di mitra . Un agguato a Strongoli mentre era in macchina con un amico Michele Benincasa, che ferito gravemente, si salvò perché un’ambulanza che era già da quelle parti lo portò via appena in tempo. Il passaggio investigativo successivo porta gli inquirenti nel cuore della faida : è lì che comincia la ricerca del movente, dei mandanti, degli esecutori. Poi il campo si restringe a una famiglia considerata avversaria dei Castiglione e a un solo nome, quello del ventiseienne Bernardino Adamo , anche lui del paese , ma da qualche tempo emigrato a Perugia per lavoro e residente con la vittima. Insomma un amico insospettabile. Mica tanto amico e neppure tanto insospettabile. Intanto dopo tre mesi lo arrestano, ma per il possesso abusivo di una pistola (che non è l’arma del delitto, si appurò poi) e per altri reati. L’omicidio di Perugia gli viene contestato in carcere. Lui nega e a ogni interrogatorio dice di essere innocente. Il gip Wladimiro De Nunzio- ritenendo sufficienti le prove – lo rinvia a giudizio il 13 maggio 1992 . Al processo, il 3 ottobre, il piemme Michele Renzo elenca una serie di prove che accusano il coinquilino della vittima. A cominciare dalla positività al tampone dello Stub che, appunto, ha rilevato tracce di polvere da sparo sulle mani dell’imputato. E poi più che indiziaria la ricostruzione di un viaggio in Calabria fatto per gli ultimi accordi con i boss che gli avevano ordinato di esportare la faida con una semiatomatica. La pubblica accusa chiede il massimo della pena. La Corte d’Assise d’Appello resta in camera di consiglio fino al tardo pomeriggio. La sentenza viene letta poco prima delle 21 ed è condanna all’ergastolo. I giudici stabiliscono che il mandato di morte era stato firmato dai rivali dei Castiglione. E che Bernardino Amato aveva accettato quel mandato per salire di un gradino nella scala gerarchica dell’organizzazione criminale. (da Il Messaggero)-
I primi spari della faida tra due famiglie della ‘ndrangheta si erano sentiti a Strongoli. Pistole e kalashnikov avevano fatto fuoco in tutta la provincia di Catanzaro per stabilire chi fosse il padrone del mercato della droga e degli altri affari sporchi che danno soldi e potere. Poi il crepitìo delle armi si sentì anche più a nord. Fino a Perugia, dove il 26 aprile 1991 i proiettili 7,65 di un intero caricatore fecero l’ennesima vittima. Aveva 23 anni , si chiamava Luigi Castiglione e tre anni prima era arrivato dalla Calabria per fare il muratore a Magione. E’ un anonimo che poco prima delle 21 chiama il ”113” , camuffata la voce, sintetica la prosa : “tra Elce e San Marco ci sono un’ auto e un morto ammazzato”. Un quarto d’ora e una pattuglia individua il posto: è il parcheggio di un albergo noto più che altro per il ristorante. Gli agenti vedono prima una macchina, poi un corpo steso per terra, e tanto sangue intorno. Luigi Castiglione è vivo, il telefonista s’è sbagliato. Ma di poco: la missione dei killer si completerà tra meno di tre ore quando il giovane morirà sotto i ferri di una sala operatoria del Silvestrini. Le indagini , coordinate dal sostituto Michele Renzo, con un giro sui terminali, accertano che la vittima aveva precedenti gravi e significativi: droga, tentato omicidio associazione mafiosa. Accertano anche che un suo fratello Francesco, 26 anni, era stato ucciso un anno prima, il 7 febbraio, con una raffica di mitra . Un agguato a Strongoli mentre era in macchina con un amico Michele Benincasa, che ferito gravemente, si salvò perché un’ambulanza che era già da quelle parti lo portò via appena in tempo. Il passaggio investigativo successivo porta gli inquirenti nel cuore della faida : è lì che comincia la ricerca del movente, dei mandanti, degli esecutori. Poi il campo si restringe a una famiglia considerata avversaria dei Castiglione e a un solo nome, quello del ventiseienne Bernardino Adamo , anche lui del paese , ma da qualche tempo emigrato a Perugia per lavoro e residente con la vittima. Insomma un amico insospettabile. Mica tanto amico e neppure tanto insospettabile. Intanto dopo tre mesi lo arrestano, ma per il possesso abusivo di una pistola (che non è l’arma del delitto, si appurò poi) e per altri reati. L’omicidio di Perugia gli viene contestato in carcere. Lui nega e a ogni interrogatorio dice di essere innocente. Il gip Wladimiro De Nunzio- ritenendo sufficienti le prove – lo rinvia a giudizio il 13 maggio 1992 . Al processo, il 3 ottobre, il piemme Michele Renzo elenca una serie di prove che accusano il coinquilino della vittima. A cominciare dalla positività al tampone dello Stub che, appunto, ha rilevato tracce di polvere da sparo sulle mani dell’imputato. E poi più che indiziaria la ricostruzione di un viaggio in Calabria fatto per gli ultimi accordi con i boss che gli avevano ordinato di esportare la faida con una semiatomatica. La pubblica accusa chiede il massimo della pena. La Corte d’Assise d’Appello resta in camera di consiglio fino al tardo pomeriggio. La sentenza viene letta poco prima delle 21 ed è condanna all’ergastolo. I giudici stabiliscono che il mandato di morte era stato firmato dai rivali dei Castiglione. E che Bernardino Amato aveva accettato quel mandato per salire di un gradino nella scala gerarchica dell’organizzazione criminale. (da Il Messaggero)-